La capacità di comunicare con le parole è una dote un po’ particolare. Tutti più o meno sappiamo leggere e scrivere, ma non sempre riusciamo a esprimerci nella maniera migliore. Spesso finiamo per dare questa capacità un po’ per scontata nella nostra vita, indipendentemente dal lavoro che svolgiamo. Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e consulente linguistica dell’Accademia della Crusca per un ventennio, si fa strada nel grande mistero della lingua italiana passando in rassegna alcune delle nostre abitudini linguistiche più frequenti e mettendoci di fronte a situazioni quotidiane in cui ognuno di noi può imbattersi facilmente, aiutandoci a comprendere che la vera libertà di una persona passa attraverso la conquista della parole che padroneggia e sceglie di utilizzare.
1. Che cos’è una lingua (e a cosa serve)
«Dunque, noi parliamo perché è il modo più economico, perfezionato nel corso di decine di migliaia di anni di evoluzione, per trasmetterci le informazioni».
Le funzioni di una lingua, e più precisamente in questo caso della lingua italiana, sono tre:
Il definire sé stessi. Ogni parola che scegliamo o non scegliamo di utilizzare nel nostro quotidiano racconta qualcosa di noi, di ciò che siamo o non siamo. Attraverso la lingua e le parole compiamo atti di identità. Per mezzo della parola dichiariamo di far parte o meno di una comunità, che è anche linguistica. Non a caso Manzoni, nel componimento Marzo 1821, scritto in occasione dei moti carbonari piemontesi di quell’anno, esprime l’augurio di un popolo italiano unito, parlando di una gente (dal latino gens, ovvero stirpe) che sia una d’arme, di lingua, d’altare | di memorie, di sangue e di cor.
Descrivere il mondo che ci circonda. Noi abbiamo un grande potere, quello di nominare le cose. In questo modo siamo in grado di metterne in luce diversi aspetti. E come suggerisce il caro zio Ben, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ma c’è ancora di più: le lingue che parliamo ci condizionano, e condizionano il modo stesso in cui vediamo e sentiamo il mondo. E viceversa, ovviamente. Parlare più lingue ci apre portali immensi che affacciano su culture altre.
Comunicare con gli altri. Condizione imprescindibile dell’uomo in quanto essere umano e in quanto animale sociale.
«Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto» in John Donne, The Works of John Donne, a cura di Henry Alford, John W. Parker, Londra 1839, vol III, pp. 574-75.
«No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main; […]»
Ma che cos’è una lingua?
La lingua, qualsiasi lingua, è un codice condiviso da una comunità di parlanti. Cosa significa questo? Che i membri della comunità devono essere d’accordo e riconoscere la corrispondenza fra significante e significato. Questa corrispondenza, come diceva il grande linguista Ferdinand de Saussure, è arbitraria, ma una volta stabilita resta tendenzialmente sempre la stessa. Come spiega Vera Gheno «in termini più semplici: non c’è un vero motivo per cui la ciliegia si debba chiamare ciliegia e non, per esempio litchi. Ma dal momento che la ciliegia è stata definita come “il frutto del ciliegio, costituito da una piccola drupa succosa di colore variabile dal rosa al rosso intenso” (Zingarelli 2019), sarebbe sbagliato chiamarla litchi o anche Ermenegilda: violeremmo quel contratto silenzioso tra noi, parlanti dell’italiano, in base al quale siamo tutti d’accordo di chiamare ciliegia la ciliegia».
Un aspetto interessante della comunicazione, sul quale bisognerebbe riflettere, è che di solito tendiamo a dare più importanza a chi comunica, all’emittente, rispetto invece a chi ascolta, all’uditore. La comunicazione che funziona veramente ha invece una caratteristica precipua, nessuno degli attori coinvolti deve essere in condizione di passività. Anche chi ascolta ha un ruolo centrale del processo, nell’economia della creazione del testo (dal latino textus, alla base anche del termine tessuto). «Il testo, come il tessuto, è qualcosa che creiamo intrecciando i fili del discorso; l’etimologia racconta sempre tanto delle parole!»1.
La conoscenza linguistica, ricordiamoci, non ha confini. Teoricamente il nostro cervello può apprendere una quantità infinita di lingue. Nasciamo con una pre-competenza linguistica che ci portiamo dentro sin da prima della nascita, e che ci permette, esposti ai giusti stimoli, di imparare la nostra lingua madre. In Italia siamo fortunati e fortunate, siamo esposti fin da piccoli almeno a un paio di lingue (l’italiano e il dialetto) perciò abbiamo una predisposizione innata al bilinguismo. Nessuna vergogna, dunque, a usare il dialetto nei momenti in cui è appropriato farlo, come per esempio in famiglia. «Il cittadino perfetto del presente, in Italia, dovrebbe essere per lo meno trilingue: conservare il dialetto, che lo lega alle sue radici; parlare correttamente l’italiano, che è la lingua della scuola e dell’amministrazione pubblica, del sapere umanistico e scientifico; e conoscere almeno una lingua straniera, magari l’inglese ma non solo, essenziale per potersi sentire pienamente cittadino di questo presente globalizzato»2.
2. Norma, errore e zone grigie
Che cos’è e a cosa serve la norma linguistica? L’insieme di convenzioni socialmente condivise tra coloro che parlano una data lingua è detta norma linguistica. Sul sito Treccani, tale norma è definita da Giovanardi come «un insieme di regole, che riguardano tutti i livelli della lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, testualità), accettato da una comunità di parlanti e scriventi (o per lo meno dalla stragrande maggioranza) in un determinato periodo e contesto storico-cuturale»3.
È interessante la parte della definizione che dice “accettato da, non imposto a una comunità di parlanti e scriventi”. Le persone accettano di aderire alla norma linguistica (attenzione: la stragrande maggioranza, non tutte) di loro spontanea volontà, non lo fanno per non offendere la maestra delle elementari o la professoressa di lettere al Liceo, ma usano semplicemente una forma di cortesia nei confronti dell’interlocutore.
Si veda David Foster Wallace che, in Autorità e uso della lingua dove, a proposito dell’inglese (ma ovviamente è valido per tutte le lingue) dice:
[…] sembra semplicemente più «cortese» seguire le regole dell’inglese corretto […] proprio come è più «cortese» disinfestare la propria casa prima di invitare ospiti, o lavarsi i denti prima di un appuntamento galante. Non solo più cortese ma in qualche modo anche più rispettoso – sia verso il proprio ascoltatore/lettore sia verso il messaggio che si vuole trasmettere4.
Ma chi decide qual è la norma linguistica e da dove vengono quelle regole interiorizzate nel corso degli anni? Intanto va sottolineato che esistono due approcci alla norma linguistica: quello prescrittivo (come dice il nome prescrive un comportamento) e quello descrittivo (che invece si limita a prenderne atto, ovvero descrive la lingua così come viene usata dai parlanti). In questo momento, per fare un esempio concreto, ci sono varie questioni molto dibattute, prima fra tutte quella del piuttosto che usato in senso disgiuntivo, al posto del semplice o, e in alcuni casi estremi perfino al posto di e. Da un lato il piuttosto che usato al posto della o oppure della e è considerato da molti linguisti un inutile e fuorviante spreco di lettere, dall’altra parte però abbiamo noti e colti influencer linguistici che usano il piuttosto che in tal senso. Dovendo sintetizzare la diatriba, Vera Gheno dice che «la norma alla fine corrisponde a ciò che viene percepito come giusto in uno specifico momento storico e sociale»5.
Ma chi detta legge? Molto spesso questa autorità massima viene identificata con l’Accademia della Crusca, anche se spesso è accusata di essere troppo descrittivista e poco prescrittivista, ma se la lingua è fatta dall’uso, gli utenti tutti hanno un ruolo attivo nella definizione della norma. La Crusca osserva, studia, registra, consiglia, ma non impone. E forse, sinceramente, è meglio così. L’unico momento in cui si è tentato di imporre delle regole dall’alto, o almeno uno dei pochi momenti in cui si è cercato di farlo, è stato durante il fascismo, quando si cercava di praticare l’autarchia (dal greco autárkeia, ovvero «bastare a sé stesso» anche a livello linguistico, bannando (come si direbbe oggi) tutti i termini stranieri e sostituendoli con parole italiane. In questo modo sono entrate nell’uso quotidiano parole come rinfresco per buffet, rimessa per garage e tramezzino per sandwich (termine coniato da Gabriele D’Annunzio).
Gli esperti quindi «mappano» i comportamenti linguistici e cercano di comprendere le nuove tendenze della lingua, le direzioni a cui tende, ma non sono loro a decidere. Quello in fin dei conti lo fa la massa dei parlanti.
In ultimo vengono sfatati un paio di miti: i giovani non sono la rovina dell’italiano e l’inglese non sta portando alla distruzione la nostra lingua. L’essere umano, con la sua scarsa propensione al cambiamento, tende a guardare con sospetto ai fenomeni che non comprende appieno. Per quanto riguarda la seconda affermazione poi l’Italia, proprio per la sua posizione in mezzo al Mediterraneo, è stata da sempre esposta a una miriade di influssi culturali, e di conseguenza linguistici: vi si trovano lemmi provenienti dall’inglese, ma anche da una decina di lingue diverse, fra cui francese, arabo, tedesco, spagnolo, turco, russo e giapponese.
3. Il grande mistero dell’italiano
Sappiamo tutte e tutti che l’italiano discende dal latino, e possediamo vari documenti che ne attestano la fase di passaggio dal latino al cosiddetto volgare (non perché grossolano, ma perché era la lingua parlata dal volgo, cioè dal popolo). Tra i documenti che meglio identificano il passaggio in corso dal latino al volgare abbiamo un vero e proprio graffito, una scritta incisa sul muro sulla catacomba di Commodilla a Roma, in zona Ostiense: non dicere ille secrita a bocce «non recitare le (cose che devono rimanere) segrete a voce alta». Qui il betacismo (il passaggio dalla v alla b) e il raddoppiamento fonosintattico (la pronuncia doppia della consonante di inizio parola quando quella precedente finisce con vocale in origine seguita da consonante, dopo a anche nell’italiano standard di base toscana), anche se la seconda b è stata aggiunta a posteriori come correzione, sono una testimonianza di scrittura semicolta, molto lontana dalla scrittura degli intellettuali. Questo ci riporta immediatamente a una questione attuale anche oggigiorno, ovvero la costante distanza tra la lingua italiana dell’élite culturale e quella del «popolo». Ma ricordiamoci anche che l’italiano è una delle poche lingue di cui tutti possono ancora adesso leggere con facilità testi molto antichi, cosa che non accade con l’inglese di Geoffrey Chauser, ad esempio. I motivi storico-culturali specifici che hanno permesso che l’italiano si conservasse quasi inalterato nel corso dei secoli, vanno ricercati nel fatto che, quando Pietro Bembo, nel Cinquecento, stila le Prose della volgar lingua, trattato considerato la prima grammatica dell’italiano, non si rifà alla lingua parlata dai suoi contemporanei, ma a quella di Dante, Petrarca e Boccaccio. La norma quindi nasce già con una interessante anomalia: è un recupero «vintage» (come lo definisce Vera Gheno) di una lingua di due secoli prima e «per di più con una specifica varietà regionale».6 Strano, non pensate? Poteva anche accadere che l’italiano si costruisse sul siciliano, altro dialetto dotato di una tradizione letteraria vera e propria.
Ma chi parlava questo benedetto italiano, su cui intellettuali di varie epoche si accapigliavano? Arrivando al 1861 e all’Unità d’Italia, c’è una frase di Massimo D’Azelio che sintetizza molto bene lo stato della lingua “nazionale”, appena dopo l’unione, ed è: «fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani». Al momento dell’unificazione infatti, secondo Tullio de Mauro, solo il 2,5% della popolazione parlava correttamente italiano, e per di più soprattutto – guarda caso – nelle regioni centrali dell’Italia.
Per far diventare italofoni gli italiani si agì su più fronti: l’obbligo scolastico da un lato (fortemente osteggiato dai genitori dei bambini che servivano come manodopera nei campi) e il servizio di leva, dall’altro, che costringeva ragazzi provenienti da regioni differenti a capirsi tendendo tutti assieme verso una koiné, ovvero una lingua comune.
I primi rudimenti di una lingua nazionale.
Ma ci vollero ben oltre cento anni per arrivare a un estendersi sufficiente dell’italiano come lingua parlata, e la diffusione della televisione, che nel 1954 aveva iniziato le trasmissioni della Rai, fu una rivoluzione.
Insomma, cento anni per arrivare all’italofonia, dopo circa settecento anni di immobilità dovuta al fatto che nessuno parlava davvero la lingua italiana. La lingua d’uso finalmente si distacca dal canone scolastico, un fenomeno che i linguisti chiamano abbassamento dello standard, e favorisce la formazione di neologismi e l’inclusione di parole provenienti o prese in prestito dalle lingue straniere.
4. Il lessico dell’italiano e come si espande
Ma quante sono in tutto le parole dell’italiano? Risposta molto ardua da dare. Nel Gradit si contano circa 328 mila lemmi, ma ci sono anche dizionari dell’uso, ovvero più specifici in questo determinato periodo storico. Ma è poco rilevante sapere quante parole contiene l’italiano, se si pensa al fatto che ne conosciamo davvero solo una minima parte. Una persona alla fine dei suoi studi superiori, conosce mediamente fra le 15 mila e le 30 mila parole. Un linguista arriva a conoscerne anche 100 000, secondo Massimo Arcangeli, che effettua uno studio basandosi sulla propria capacità linguistica.
Come fare allora a scegliere la parola più adatte a uno specifico contesto? Semplice, ragionando sul contesto in cui dobbiamo impiegare quella parola. Che succede se scegliamo la parola meno adatta ad uno specifico contesto d’uso? Numerosi potenziali problemi: potremmo essere fraintesi, oppure offendere qualcuno non volendo, non farci capire o fare anche la figura degli ignoranti. Ecco perché è molto importante saper interpretare intelligentemente le varie esigenze di comunicazione.
5. Potere alle parole!
Se dovessi fare un’unica considerazione su questo libro, sceglierei proprio quella che per me è la più rilevante: considerato che la linguistica è una competenza trasversale a tutte le altre e che proprio dalla competenza linguistica nasce la possibilità di trasgredire le regole senza apparire superficiali, conviene darsi da fare per studiare le basi normative della nostra lingua, prima di tutto a scuola. Una salda competenza linguistica, nel settore culturale come in ogni altro settore, ci permette di esercitarci nella variazione di registro, ponendoci sempre alcune domande preliminari rispetto a come dobbiamo comunicare: in che contesto opero? Chi sono i miei interlocutori attuali? Qual è il mio scopo comunicativo oggi? E domani? Attraverso le nostre scelte lessicali raccontiamo noi stessi, e le parole sono responsabilità di ognuno di noi. «Se siamo intelligenti, possiamo evitare che siano gli altri a imporci le loro parole, e le loro conseguenti visioni del mondo. Questo non solo ci fa evitare di parlare a vanvera, ma ci dà anche la possibilità di diventare dei veri e propri influenzatori culturali», aggiunge Vera Gheno.
Coltiviamo il dubbio fecondo, alla base della possibilità di continuare ad aumentare le proprie competenze e conoscenze. Vinciamo la resistenza dei nostri pregiudizi. Riprendiamoci il lusso della riflessione. Nonostante tutto oggi ci porti a credere che la velocità nella comunicazione sia essenziale, prendiamoci delle piccole pause per pensare bene a ciò che stiamo per dire. Ripensiamo alla rilevanza del silenzio. Non occorre avere sempre un’opinione su tutto, non riempire ogni vuoto con le parole. Possiamo scegliere di tacere, al momento ritenuto più opportuno. Questo non significa non fare domande, ma evitare di parlare di argomenti di cui non si è realmente competenti contribuirebbe a migliorare la sfera della comunicazione anche nel proprio ambito di competenza. C’è fin troppa foga di non lasciare non-detta nemmeno una parola, come per una specie di horror vacui, per non differenziarsi dalla massa.
- Vera Geno, Potere alle parole. Perché usarle meglio, Giulio Einaudi Editore, Torino 2019, p. 18.
- Vera Geno, Potere alle parole. Perché usarle meglio cit., p. 22.
- Claudio Giovanardi, L’italiano da scrivere. Strutture, risposte, proposte, Liguori, Napoli 2010, p. 17 in Vera Geno, Potere alle parole. Perché usarle meglio cit., p. 29.
- Foster Wallace, Considera l’aragosta, Einaudi, Torino 2014, p. 101 in Vera Gheno, Potere alle parole. Perché usarle meglio cit., p. 30.
- Vera Gheno, Potere alle parole. Perché usarle meglio cit., p. 38.
- Vera Gheno, Potere alle parole. Perché usarle meglio cit., p. 70.
In copertina: illustrazione di Beppe Giacobbe.
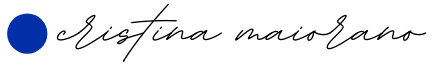

0 commenti